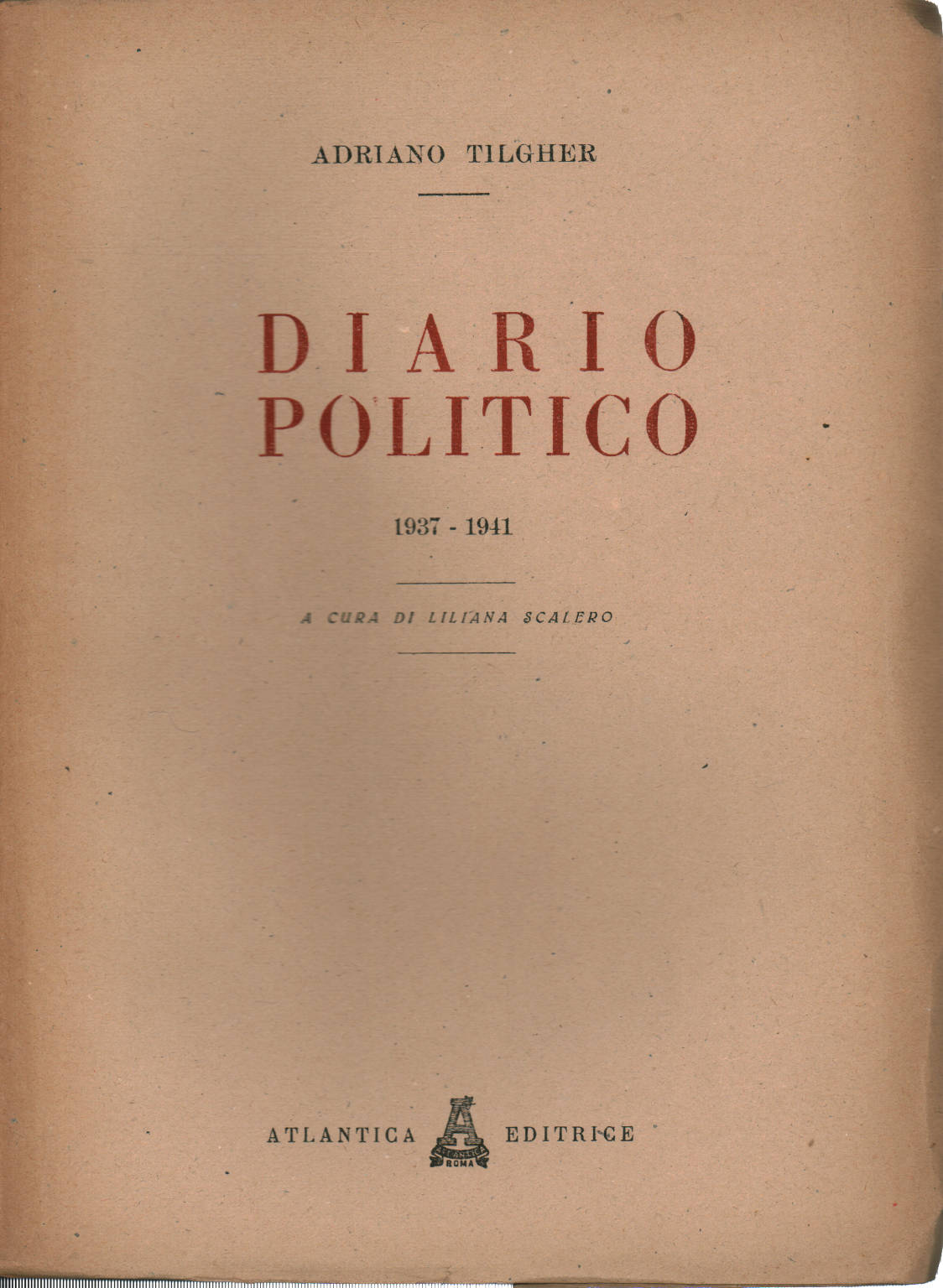Adriano Tilgher (1887-1941) ha commesso una serie di errori, in vita, e ha avuto una serie di sventure, in vita e dopo, e questo non ha giovato alla durata del suo nome. Che di fatto non è durato: i suoi molti libri – molto letti, venduti e tradotti nell’entre-deux-guerres – oggi generalmente non si leggono, non si citano e non si ristampano più, con qualche isolata e molto meritoria eccezione (in particolare, la ristampa dei saggi su Leopardi a cura di Raoul Bruni per Aragno e quella del pamphlet contro Giovanni Gentile a cura di Gabriele Turi per Storia e Letteratura).
Gli errori: avere avuto un atteggiamento ondivago nei confronti del regime fascista, a cavallo tra gli anni Venti e Trenta, e non essere stato abbastanza scaltro da dissimulare queste oscillazioni. Nell’aprile del 1928 Tilgher stroncò sulla «Stampa» la Storia d’Italia dal 1871 al 1915 di Croce e negli anni successivi si avvicinò al regime – lui che nel 1925 aveva firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti – forse per convinzione, forse per paura o per opportunismo, forse per acquiescenza a un male che credeva ormai inevitabile. Come tanti altri intellettuali, negli anni che segnarono l’acme del consenso al fascismo, quando – come ha scritto De Felice – esso si presentava come «una realtà, ancor prima che impossibile a rompere dall’interno, paralizzante e che, per di più, per un verso, si autosviluppava e, per un altro verso, si autocelava ai più con la forza […] di ciò che è, di ciò che assicura un ordine (che, tutto sommato, è fonte di garanzia e di sicurezza) e di ciò che non ha alternative».
Altro errore: lasciare l’impiego di bibliotecario e vivere solo della propria attività di pubblicista: il che lo sottomise al dispotismo dei direttori di giornale e ai capricci del potere politico (la stroncatura di Croce venne concordata con il capo dell’ufficio stampa di Mussolini, Giovanni Capasso-Torre). E infine, nuovo errore, non solo dire male di Benedetto Croce ma dire malissimo di Giovanni Gentile in un momento (Spaccio del bestione trionfante, 1925) nel quale Gentile non era più ministro ma era ancora ovviamente, e sarebbe rimasto, una delle figure più in vista dell’establishment culturale italiano. Quanto alle sventure, una sopra tutte: ri-convertirsi all’antifascismo nel corso degli anni Trenta ma morire presto, sia diciamo oggettivamente, a 54 anni, sia soggettivamente, prima che, terminata la guerra, gli fosse data l’occasione, che ad altri fu data, di spiegarsi, giustificarsi, cambiare idea e casacca, e anche far valere qualche benemerenza (una decennale sorveglianza da parte della polizia politica e negli ultimi anni, tra l’altro, la probabile collaborazione con Giustizia e Libertà).
Esistono due tipi di saggisti: quelli che illustrano la loro visione del mondo senza bisogno di mediazioni, dicendo che cosa pensano di questo o quel fatto, o costume, o ideale; e quelli che preferiscono parlare della visione del mondo degli altri, discutendo i loro libri, in modo che attraverso la discussione venga fuori la loro. I più interessanti tra gli scritti di Tilgher cadono in questa seconda famiglia. Poco incline ai grandi sistemi filosofici, nonostante avesse studiato e tradotto gli idealisti tedeschi, dotato di una sterminata cultura e di un talento analitico fuori del comune, per più di un ventennio Tilgher si occupò di una gamma incredibilmente ampia di argomenti, dai filosofi antichi al teatro contemporaneo, dalla storia del cristianesimo a Cechov, dall’analisi del concetto di lavoro al socialismo. Era un maestro della recensione more antiquo, cioè non la sbrigativa recensione-segnalazione che usa oggi ma l’ampia e approfondita discussione di un libro e del pensiero di un altro autore. Gli esperti di storia della letteratura ne ricordano gli studi su Pirandello, e forse anche quelli su Leopardi. Li ricordano, di solito, senza veramente averli letti, li ricordano filtrati dalle storie della critica, o attraverso le citazioni – poche e fredde – di scrittori come Sciascia (per Pirandello) e di studiosi come Luporini o Timpanaro (per Leopardi). Ma leggere quegli studi significa fare o rifare la conoscenza con un’intelligenza critica fuori del comune, capace di quella sintesi tra teoresi e interpretazione dei testi che riesce a pochissimi (vedi per esempio il modo in cui applica le categorie di Bergson alle trame e ai personaggi pirandelliani; vedi la valorizzazione, ancora rara a quell’epoca, dopo l’interdetto di Croce, del pensiero filosofico di Leopardi).
Verso la fine della sua vita, Tilgher tentò la prima delle due strade del saggismo che ho indicato sopra: non la discussione del pensiero altrui ma la dichiarazione del proprio, in un volumetto che venne pubblicato postumo, nel 1946, a cura dell’amica Liliana Scalero. In questo Diario politico Tilgher raccolse una serie di annotazioni scritte tra la primavera del 1937 e l’autunno del 1941, poche settimane prima della morte. Erano annotazioni che avrebbero forse dovuto essere assorbite in un saggio di teoria politica: nelle prime pagine dell’autografo, conservate alla Biblioteca Nazionale di Roma, Tilgher elabora articolate definizioni della democrazia e del liberalismo; ma, a mano a mano che le pagine si accumulano e la riflessione va avanti (intanto scorrono gli anni: le democrazie europee barcollano, l’Italia entra in guerra, l’Europa intera sembra dover diventare un feudo hitleriano), il filo teorico s’interrompe e s’intreccia a considerazioni che più che al filosofo della politica fanno pensare al moralista, all’osservatore di costumi che di lì a qualche anno, se fosse vissuto, avrebbe potuto trovare ospitalità sul «Mondo» di Pannunzio, insieme ad altri scettici liberali come Brancati o Flaiano.
L’edizione curata da Liliana Scalero era piena di errori, e la si trovava con difficoltà anche nelle biblioteche. Le Edizioni della Normale ne hanno pubblicato una nuova edizione fondata sull’autografo, a mia cura. Le righe che seguono, datate 12 novembre 1939, sono un attendibile campione della prosa di Tilgher, e abbozzano un ritratto della classe dirigente che di lì a qualche mese ci avrebbe portato al massacro – e non solo di quella: «I governi più duri sono quelli dei plebei portati al potere dalla rivoluzione. Stupiti essi stessi d’esservi arrivati, ben sapendo che al loro potere manca la consacrazione del tempo e del riconoscimento universale, conoscendo per quale intreccio di casi e di eventi unico e irrepetibile sono giunti al potere, paurosi di perderlo, sono diffidentissimi, e pur di tutelarsi non indietreggiano dinanzi a nessun eccesso o violenza. Inoltre, venendo da classi prive fino allora dei beni della vita, vissute sempre fino allora nella miseria o per lo meno nello stento, sono avidissimi dei beni della vita, ci si gettano sopra come affamati, s’ingozzano, fan bottino, credono di non avere mai abbastanza nella tasca. Sono governi in cui la rapacità e la ferocia vanno di pari passo. E con la rapacità e la ferocia la vanità: pervenuti al potere, quasi non ci credono ancora, cercano di dar prova a se stessi di essere loro i padroni, ostentano i segni del potere, fanno sentire dappertutto il pugno, s’inebbriano di titoli e ciondoli».
Adriano Tilgher, Diario politico, a cura di Claudio Giunta, Edizioni della Normale, 10 euro.